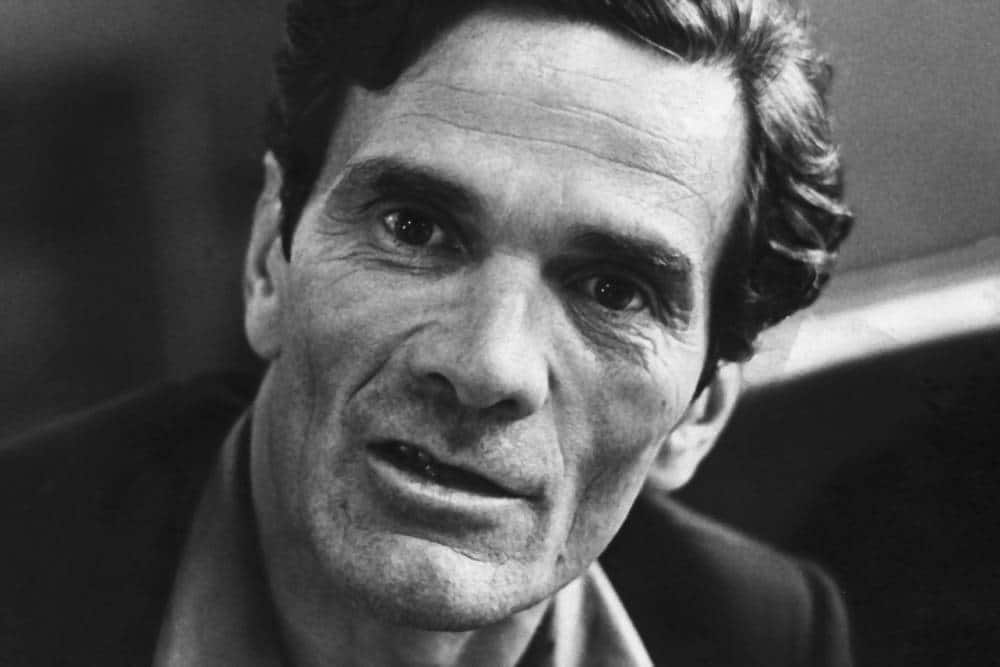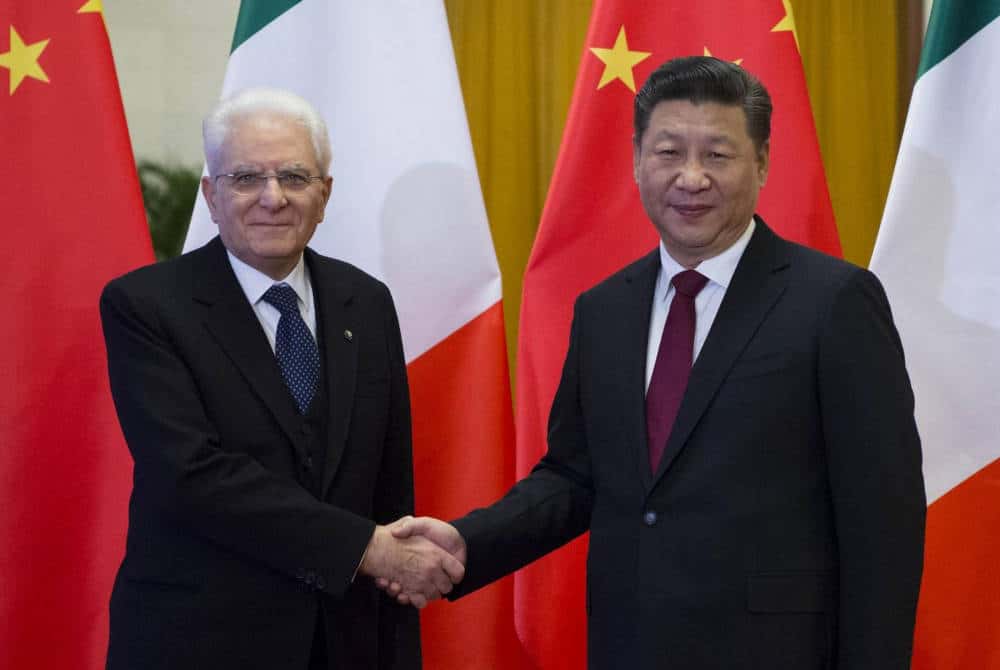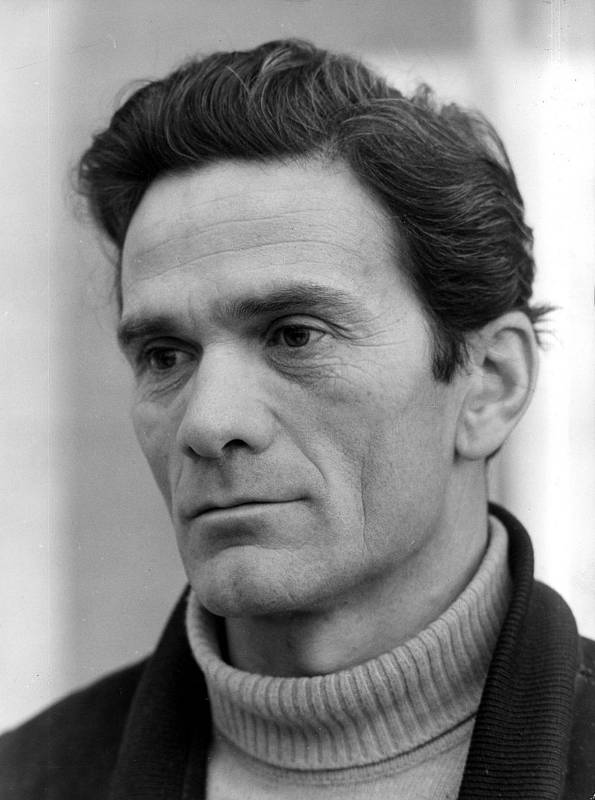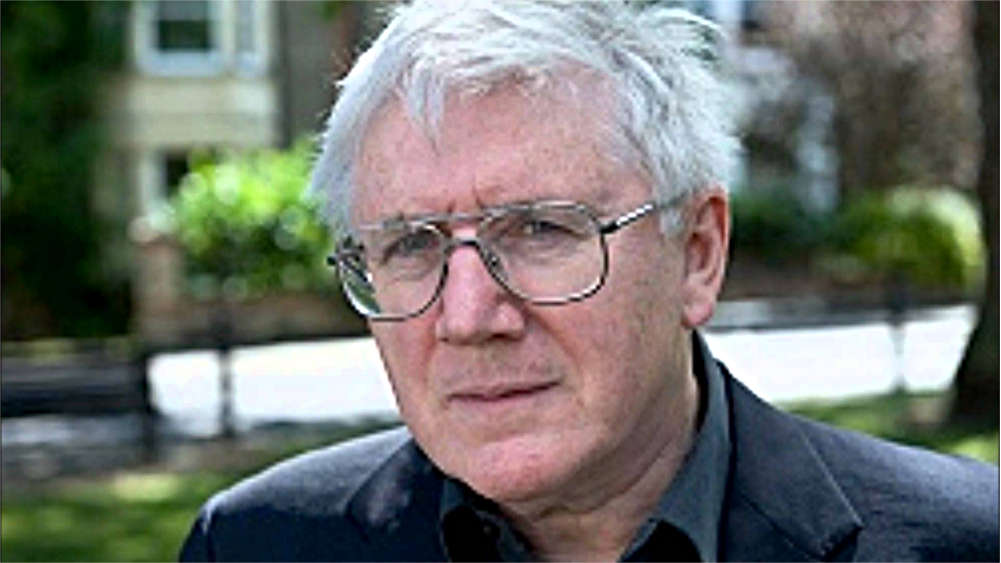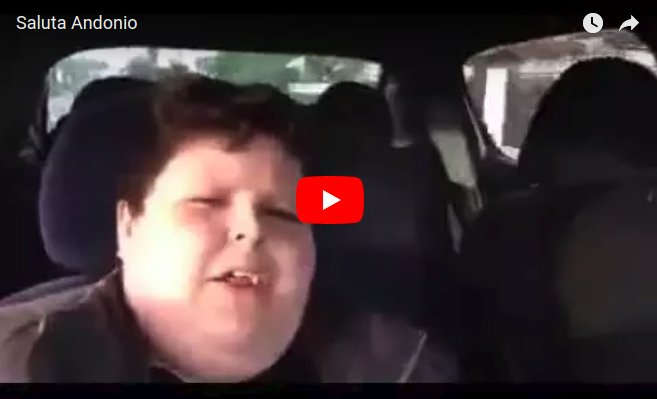All’artista Andy Warhol si attribuisce la frase in futuro tutti avranno 15 minuti di fama. Non si sa se sia veramente sua, ma è la frase simbolo di un’intera filosofia artistica e sociale che ha rappresentato l’inizio di un percorso di orizzontalità dell’essere-per-apparire e di liquidità delle sovrastrutture sociali, tanto più evidente oggi che, con i social, ognuno può, con un poco di strategia, un pizzico di fortuna, contenuti tritati, semplicistici e a portata del più becero degli analfabeti funzionali nonché con l’aiuto di qualche esperton-santone di marketing digitale, assurgere alla gloria effimera della fama a tempo determinato.
Poi, siccome i media ci sguazzano con i fenomeni da baraccone del web e con tutti i fenomeni che potenzialmente possono vendere, allora creano una singolare commistione tra il quarto potere (la stampa), il quinto potere (la TV) e quello che oggi definisco il sesto potere (internet e i social in particolare).
Oddio, seguendo la ripartizione classica dei poteri (1, legislativo, 2, esecutivo, 3 giudiziario, 4, stampa e 5, tv) arriviamo ai social come sesto potere, ma seguendo una ripartizione più razionale e storicamente attinente, direi che TV, stampa e social sono diventati, tutti insieme, il primo potere post-mediatico che domina i tre classici poteri, tanto che, s’è visto, ormai la scena politica è influenzata dal sentiment della rete, ossia da quelle reazioni popolari che si evidenziano sui social ma che sono influenzate a loro volta da tutti quei commentatori, opinionisti, giornalisti, ma anche social media manager, markettari ed esperti di comunicazione che appartengono al quarto, quinto e sesto potere.
Quindi le influenze reciproche che si sostanziano in questi strumenti vanno poi a governare le scelte politiche che non sono più liberamente determinate da un’idea, un manifesto, un programma dettato da una visione del mondo, ma da contingenze sempre mutevoli come mutevole è il sentimento di quel popolo tanto idealizzato dalla destra sovranista quanto pericoloso perché (ovviamente) incapace di dettare la linea politica, privo di guida e di strumenti per decodificare il mondo e sempre influenzabile dalle mode e tendenze del momento.
In questo quadro in cui la politica insegue l’elettorato attraverso i social, i media influenzano la gente che poi riversa sui social la mutevole pappa pronta, l’analisi viene sostituita dall’emozione, la discussione cede il passo alla tifoseria, allora il gentismo da social è alla perenne ricerca non più di un’ideale o di una visione alternativa del mondo, ma di un simbolo, che possa guidare (per i 15 minuti simbolici di Warhol) le proprie emozioni individuali e collettive, ed ecco che nascono gli eroi.

L’eroe non costruito (oggi non si costruisce più nulla, semmai si riprende, svuotando di contenuti) ma riadattato da quello di romanticista memoria, che esce fuori dagli schemi della storia, sente la propria legge morale più forte dell’etica o della legge positiva, si contrappone all’universalismo per difendere l’amor patrio, le proprie tradizioni identitarie, la giustizia naturale.
Dalla falsa riga dell’eroe romantico oggi nasce l’eroe post-mediatico, quello che sfida il potere, smuove le masse e le emozioni (non le coscienze), si fa portatore non tanto e non più di un’ideale, una visione, ma di uno o più temi, spesso di un’antistorica pretesa identitaria.
Richiamando quindi l’eroe romantico, oggi l’Italia conosce l’eroe sovranista, che sfida il potere, cavalca la paura del diverso e difende una presunta identità ormai storicamente superata nonché delle tradizioni abbondantemente distrutte dal modello consumista e che sono solo una teca da museo. Ma alla gente interessa che l’eroe salvi l’Italia dal declino, quel declino in cui lui stesso ci sguazza.
Ma l’eroe viene di volta in volta riproposto tra ciò che può avere clamore mediatico, che può vendere emozioni, ma anche generare visite, advertising, funnel e persino gadget. Ecco che il circo post-mediatico ricerca tra gli smartphone sempre connessi, simbolo del sesto potere, le condivisioni, le interazioni e il clamore suscitato dall’eroe del momento, così lo preleva, gli crea un simulacro maginifico intorno, lo stordisce, gli svuota tutti i contenuti lasciando solo il motto (o l’hastag) e lo rigetta nella mischia del gentismo che altro non vuole che riconoscersi in un simbolo, però temporaneo, che possa appagare l’emozione del momento e, come direbbe Bauman, regalare un momento piacevole, sopperire alla recondita paura dell’inadeguatezza con episodici momenti di eroismo altrui, in cui riconoscersi e per cui tifare, che regala una sensazione di rivalsa, un’emozione di subitanea giustizia, uno scuotimento momentaneo dal torpore di chi è invischiato nella melma del consumo, che altro non fa che recidere qualsiasi prospettiva programmatica, qualsiasi visione alternativa ma come contentino regala momentanee sensazioni di appagamento emotivo.
Greta, Simone, Ramy, Samir, che sono stati accomunati in quanto tutti ragazzini e tutti eroi, non sono gli eroi, sono invece diventati un oggetto di consumo del circo post-mediatico e subitaneamente gli opinionisti e i commentatori rappresentanti del gentismo interclassista e servi del modello consumistico e tardocapitalista che vuole che niente cambi ma che si regali l’illusione del cambiamento, ne hanno tessuto le lodi, additando invece chi, più adulto, è addormentato, incapace di reagire ai soprusi o di scuotere le coscienze. Cosa che invece questi ragazzini, rispettivamente nel proprio ambito d’azione, hanno fatto.
Le parole più sagge che abbia sentito finora sono state quelle del padre di Simone, 50 anni, ex operaio Almaviva, (…) anche la sinistra non può accontentarsi dell’eroe di turno. Oggi è Simone, ieri era Mimmo Lucano, l’altro ieri era il consigliere di Rocca di Papa. C’è la persona che scalda gli animi per qualche ora, ma non un vero lavoro di organizzazione.
Tra i tanti commenti letti o ascoltati in queste settimane, partendo da Greta per poi giungere a Simone, tale pensiero è il più equilibrato e saggio e sintetizza lo sminuzzamento della dialettica che ci ha condotti a questo punto: liquefatta la società, crollate le ideologie e addormentati come se fossimo in Matrix, la gente acclama l’eroe e la politica si accoda osannante, insegue il sentiment della rete e si fa dominare e manipolare (consapevolmente o no) dal primo potere: il circo post-mediatico.
Da questa vischiosità non se ne esce se non si riannodano i fili con il passato, ossia con il lavoro dialettico di ricostruzione storica e ideale che parta dalle persone di buona volontà e dagli intellettuali, non quelli inutili finti intellettuali che oggi lodano gli eroi, ma quelli che hanno anche il coraggio di evidenziarne il pericolo. E ce ne sono. Basta vedere quanti sono stati attaccati per aver espresso una voce fuori dal coro. Ricostruire la dialettica, soprattutto per mano degli intellettuali, significa anche avere il coraggio di affrontare il momento antitetico della negazione (ossia avere la gente contro) e di ritornare al momento sintetico dell’affermazione razionale come sintesi delle visioni alternative del mondo.

Per concludere, lasciatemi approfondire il punto sul confronto tra generazioni.
Chi addita noi, generazione fallita, ossia quella dei nati tra gli anni Settanta e Novanta, dicendo che i giovani di oggi sono attivi, coscienti e lottano, mentre noi siamo addormentati e abbiamo abbandonato la lotta, ricordo che abbiamo vissuto le peggiori fasi del crollo degli ideali, della liquefazione della società, dell’interclassismo, siamo stati picchiati a Genova, dove hanno scientificamente distrutto una generazione, siamo stati annichiliti nell’ideale di ricostruzione di una società che nel frattempo si stava decostruendo, siamo stati beffeggiati e derisi quando parlavamo di antiglobalizzazione e proponevamo un modello solidale, mentre oggi subiamo le conseguenze della globalizzazione e la risposta è diventata il sovranismo (come cura peggiore del male).
Siamo stati travolti dal consumismo, dall’edonismo voluto da chi, prima di noi, ha coscientemente iniziato il processo di abbandono dell’umanità, delle campagne, delle periferie della civiltà, della cultura popolare, per sposare la causa del benessere, dell’auto nuova, della seconda casa al mare, del cibo spazzatura edulcorato dall’invasiva pubblicità, degli status symbol, dei personaggi cicaleggianti nei talk show (mi perdoni Francesco se gli rubo l’espressione), delle copertine satinate che rappresentano modelli innaturali da perseguire a ogni costo e del conseguente edonismo di massa.
Ero bambino quando sono stato bombardato da un modello che tutti hanno preferito a quello scomodo e poco appetibile del socialismo, della solidarietà. Nei ruggenti anni Ottanta ci hanno insegnato a prevaricare, a far carriera, ad inseguire ideali materialisti, a svincolarci dai lacci e laccetti della morale cattolica o di qualsiasi altra morale, come fosse un macigno inutile al cospetto della leggerezza dell’avere.
Negli anni Novanta tutti plaudivano Prodi quando parlava di smantellare lo Stato sociale, privatizzare tutto ed alleggerire il mostro burocratico e nel frattempo, mentre le prime avvisaglie di una crisi non solo economica ma sociale iniziavano a palesarsi, tutti si sono fatti rimbecillire dal modello tette&culi proposto dalle reti televisive di Berlusconi (quindi dalla mercificazione della donna) e dall’americanizzazione invadente, fatta di armi di distrazione di massa e consumo usa&getta, che oggi vale non solo per le cose, ma anche nei rapporti umani.
Mentre accadeva ciò noi crescevamo, ci indignavamo, protestavamo in piazza e venivamo derisi dagli uni e abbandonati dagli altri, che nel frattempo distruggevano la quasi centenaria esperienza del PC e abbracciavano il riformismo e il modello capitalista. Insomma, lottavamo sia dentro che fuori le mura della politica domestica. E oggi quella stessa gente, unita a sconosciuti opinionisti venuti dal nulla del circo post-mediatico, addita noi e ci propone come modelli dei ragazzini che sì, sono migliori, lo sono sicuramente, ma sono dati in pasto agli squali.
A questi ragazzi e a tutti gli adolescenti dico solo: non fatevi fregare anche voi. Quando vedete uno smartphone puntato in faccia, sputate nell’obiettivo. Quando vi additano come modelli o come eroi, spostate il dito da un’altra parte. Se noi venivamo derisi, voi sarete tritati, masticati e sputati nel circo post-mediatico, ad uso e consumo della gente.