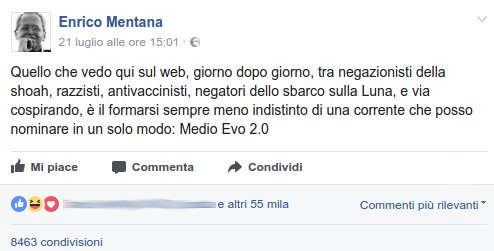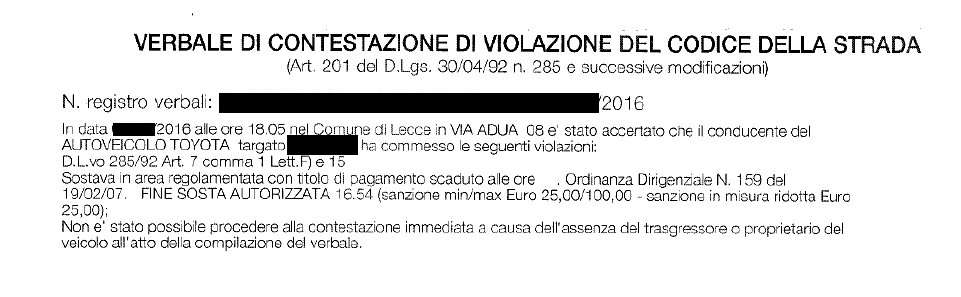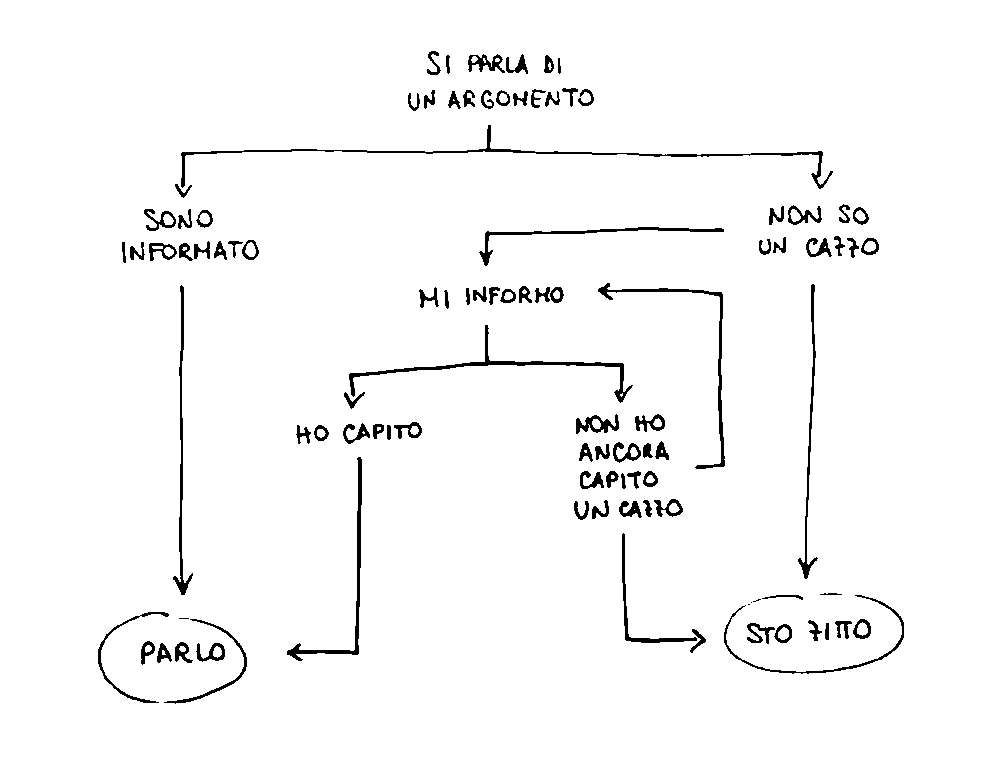Cos’è la cultura? Quante definizioni ha? A cosa ci serve? Perché è importante riprendere la discussione sul tema? Con questo articolo cerco di dare tutte le definizioni possibili del concetto di “cultura” e di focalizzare l’attenzione su un tema di fondamentale importanza nei decenni a venire.
Il termine cultura ha trovato, nel corso della storia, una sovrabbondanza di significati tanto da risultare quasi impossibile una classificazione. Abraham Moles, nel 1967, faceva riferimento all’esistenza di più di 250 definizioni di cultura. Gli antropologi Kroeber e Kluckhohn tentarono di impostare una definizione di cultura di validità universale, ma registrarono circa 150 concezioni differenti.
Solo per fare qualche esempio, al giorno d’oggi si può utilizzare il termine in questione per una svariata cerchia di contesti:
”Ci sono enormi differenze culturali tra Oriente e Occidente”
”Umberto Eco è una persona di grande cultura”
”La musica pop è usata dai gruppi giovanili per affermare la loro identità culturale”
”La cultura di massa ha un effetto di omologazione”
”Le telenovela sono espressione della cultura sudamericana”
”La cucina italiana è parte della tradizione culturale del nostro Paese”
”Il dialogo tra le culture è necessario, ma difficile”
Ecco che possiamo trovare, in questi esempi, diverse concezioni di cultura. A grandi linee si può affermare che esiste un significato quantitativo (ossia il complesso di nozioni e conoscenze che un individuo possiede) o un significato sociologico, per cui in un gruppo sociale assumono una notevole importanza le rappresentazioni collettive, cioè gli insiemi di norme e credenze che il gruppo possiede. Esiste una concezione antropologica (che, del resto, ha fortemente influenzato quella sociologica), per cui la cultura rappresenta un insieme di norme, di credenze, di abitudini quotidiane più o meno accettati da tutti in una determinata comunità.
Ma procediamo con ordine. Per chiarire la portata di tali significati occorre soffermarsi sulle concezioni di cultura che, dalla civiltà Greca e Latina ad oggi, hanno caratterizzato tale termine, rendendolo un concetto diversamente interpretabile e altamente indeterminato, considerando lo sviluppo che tale termine ha avuto nelle diverse epoche storiche.
Cultura come processo di coltivazione
Il termine, di origine latina, deriva dal verbo colere, che significa “coltivare” e veniva dunque impiegato per indicare qualsiasi manipolazione della natura ad opera dell’uomo. Ma anche oggi si intende come l’insieme dei sensi operativi, legati al lavoro agricolo ed ai suoi risultati o all’allevamento di microrganismi (la cultura o coltura dei virus, della vite, dell’olivo, etc.).
I latini utilizzavano questo termine, però, non solo per indicare tale rapporto tra la natura e l’uomo, ma anche, insieme al termine anima, per indicare il processo di coltivazione, ossia di educazione, della propria anima, così come si coltiva la terra, quindi la cultura indica un processo di coltivazione dell’uomo attraverso tutta una serie di procedimenti e di processi di apprendimento (cultura animi). Inoltre l’aggettivo cultus (l’etimologia è analoga) stava a designare tutto ciò che si rivela curato, lavorato, coltivato e s’oppone quindi agli aggettivi silvester o neglectus. Da qui il termine culto, che viene utilizzato per tutte quelle situazioni che richiedono una cura assidua, una cura verso gli dei o una cura verso l’essere umano.
In tale prospettiva, il concetto di cultura è apparentato a quello di coltivazione, ossia ad un intervento mirante a sviluppare qualcosa che se non fosse curato, perirebbe o non nascerebbe affatto. Cultura, insomma, come agri-coltura o, anche, come cultura fisica o culturismo, che denota una pratica ginnica tendente a rafforzare il volume e la potenza della muscolatura.
Il termine cultura, nel significato appena illustrato, nonostante sia stato, in un certo senso, superato dalle interpretazioni successive, possiede una intrinseca caratteristica che lo rende attuale e rappresenta comunque il punto di partenza per una comprensione complessiva del termine. Sia perché, ad ogni modo, indica sempre un processo di crescita, sia perché dalla concezione di cultura come cultus (ossia “coltivazione degli esseri umani” o meglio, la loro educazione) deriva il valore di cultura nel suo senso moderno: il complesso di conoscenze (tradizioni e saperi) che ogni popolo considera fondamentali e degni di essere trasmessi alle generazioni successive.
E’ interessante notare che Jesús Prieto de Pedro, nella ricostruzione definitoria del termine cultura, segnala come il significato moderno del lemma sia acquisizione linguistica relativamente recente, infatti nel Dictionnaire Universel di Antoine Futière del 1690, il termine viene usato nel suo senso originario.
Cultura come attività intellettuale superiore
Cultura può essere interpretata in una diversa accezione: “complesso delle conoscenze intellettuali e delle nozioni che contribuisce alla formazione della personalità”. In altre parole indica l’insieme dei sensi intellettualistici, valutativi, per cui cultura connota attività per così dire superiori, intellettualmente qualificate, non esecutive, ed i prodotti di esse. Ma occorre ancora distinguere, all’interno di questa definizione, tra cultura come giudizio di valore e cultura come concetto descrittivo. Nella prima definizione cultura si contrappone ad ignoranza; in un altro senso essa indica “l’insieme delle cognizioni, e delle disposizioni così mentali come sociali, al cui acquisto è necessaria, quantunque non sufficiente, una vasta e varia lettura”.
La seconda definizione apre, per così dire, la strada verso la nozione antropologica del termine. Ossia la cultura identifica un ordine di fenomeni esclusivamente umani (gli animali non hanno in senso proprio una cultura, ma semmai un modo di vita) a carattere sociale.
Il termine cultura come giudizio di valore indica lo specifico patrimonio di conoscenze di cui una persona si è impadronita (è uno dei significati correnti del termine cultura) e può essere accostato al termine greco paidéia e al latino humanitas: il primo indicava il modello educativo in vigore nell’Atene classica e prevedeva che l’istruzione dei giovani si articolasse secondo due rami paralleli: la paideia fisica, comprendente la cura del corpo e il suo rafforzamento, e la paideia psichica, volta a garantire una socializzazione armonica dell’individuo nella polis, ossia all’interiorizzazione di quei valori universali che costituivano l’ethos del popolo. Mentre con il secondo si intende una concezione etica basata sull’ideale di un’umanità positiva, fiduciosa nelle proprie capacità, sensibile e attenta ai valori interpersonali e ai sentimenti. Ciò che conta è che questo ideale è valido per tutti gli uomini, senza distinzioni etniche, sessuali o sociali. Terenzio scriveva appunto: “homo sum: humani nihil a me alienum puto”, ovvero: “sono un uomo, e perciò nulla di ciò che è umano mi è estraneo”.
Queste nozioni arrivarono sino al medioevo dove, seppur mutate le condizioni a causa dell’affermarsi del modello cristiano, resistettero le concezioni di cultura come realizzazione dell’umanità degli uomini liberi. Un passo di un’opera di dante può rappresentare la concezione della cultura in quel tempo:
“(…) l’operazione specifica del genere umano preso nella sua totalità è quella di attuare sempre tutta la potenza dell’intelletto possibile, prima mediante l’attività speculativa e poi, in forza e per estensione di questa, mediante l’attività pratica. Siccome nell’uomo singolo avviene che, vivendo in condizioni di calma e di tranquillità, si perfezioni in saggezza e in sapienza, è chiaro che — secondo il detto che ciò che vale per la parte vale per il tutto — anche il genere umano, vivendo nella quiete, cioè nella tranquillità della pace, può compiere, nel modo più libero e facile, la sua attività specifica che è quasi divina, secondo il detto: “Lo facesti di poco inferiore agli angeli”.
Nonostante il Poeta auspicasse una pace universale, dalle parole si può dedurre che “quiete e tranquillità della pace” sono caratteristiche che solo gli uomini liberi potevano possedere e che cultura indica sempre uno sviluppo delle qualità interiori umane.
Nel ‘400 cultura si identifica ancora con il termine humanitas, mentre nel sei-settecento il termine viene ripreso da filosofi come Bacone, Pufendorf e poi Leibniz e Kant allo scopo di designare il processo di formazione della personalità umana e la sua capacità di progredire.
Gli sviluppi successivi
L’affermarsi dell’Illuminismo ha portato – com’è noto – ad una rottura politico-sociale con il passato, esaltando le idee laiche e principi razionali e scientifici e coinvolgendo, nel profondo mutamento ideologico del tempo, anche il concetto di cultura: la ragione è lo strumento dell’educazione, e poiché ogni uomo è dotato di ragione la cultura può divenire patrimonio universale anziché riservato ai dotti.
Ma fu in questo momento storico (a cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento) che la concezione francese di cultura trovò un destino diverso da quella tedesca. La Germania stava attraversando un forte mutamento culturale che l’avrebbe portata, successivamente, dall’illuminismo al clima intellettuale romantico. Fu in questo momento che avvenne il trapasso dal significato “soggettivo” al significato “oggettivo” del termine cultura, ossia al passaggio da una determinazione in termini individuali a una determinazione in termini storico-sociali della cultura. Il primo esempio di impiego su larga scala del concetto di cultura in questa nuova accezione si ritrova nelle opere di J.G. Herder, in cui pone una forte contrapposizione tra cultura e civiltà.
Cultura e Civiltà
Fino all’illuminismo la cultura è legata alle facoltà superiori dell’uomo, alla sua natura razionale e morale, e quindi alla cultura può accedere in fondo soltanto una élite, una élite sociale o meglio una élite di tipo intellettuale.
Mentre Civiltà (dal latino civilitas, termine che si introduce nel latino abbastanza tardi, nel I secolo d.C., come traduzione del greco πολιτεία [politéia]) indica l’appartenenza alla civitas, ossia alla struttura politica della città, come anche ai modi di vita che sono propri della città, ai modi di vita urbani in contrapposizione ai modi di vita della popolazione rurale. Il termine è stato utilizzato spesso dall’illuminismo francese, infatti il concetto di civilisation era servito soprattutto a designare un livello di vita associata che si colloca al di là dell’esistenza asociale dei popoli selvaggi e dell’esistenza sociale, ma ancor priva di un’organizzazione razionale, dei popoli barbari. In questo modo la tripartizione tra stato selvaggio, barbarie e civiltà veniva ad indicare le grandi fasi successive dello sviluppo dell’umanità nel suo avanzamento verso uno stato finale caratterizzato dall’acquisizione dell’autonomia razionale da parte dell’uomo e dalla diffusione crescente dei “lumi”. Infatti l’illuminismo critica aspramente l’ideale aristocratico di cultura. Nel francese del sec. XVIII, però, il termine civilisation, che indicava nel secolo precedente il “buon gusto” e le “buone maniere”, acquistò il significato illuministico di cultura come potenziale patrimonio di tutta l’umanità, e quindi in lingua francese l’opposizione ideologica tra cultura illuministica e cultura aristocratico–formale non si tradusse nella contrapposizione di due parole.
Inoltre Cultura e civiltà hanno avuto, nel panorama intellettuale del Novecento, un destino assai diseguale. Il concetto di civiltà si è dimostrato più tenacemente refrattario a una definizione scientifica. Più che un concetto suscettibile di essere formulato in regole precise, la civiltà si è rivelata un’idea, talvolta addirittura un modello ideale. Anche lasciando da parte troppo scoperte esaltazioni di stampo etnocentrico della civiltà contro la barbarie, o della civiltà occidentale nei confronti di altre civiltà, le varie teorie storico-filosofiche della civiltà son servite, di solito, a discriminare in termini di valore le diverse forme di organizzazione sociale, cioè ad individuare nello sviluppo dell’umanità un livello di vita considerato “superiore”.
Il concetto di cultura è stato invece oggetto di una lunga elaborazione che ha fatto di esso un concetto-chiave delle scienze sociali. Il romanticismo tedesco ha dato il via, in un certo senso, allo studio antropologico del termine cultura. Gustav Friedrich Klemm, con le sue opere inserite nel filone che risale a Herder e in un clima in cui il Volksgeist, ossia la volontà di una nazione che rappresentava la legge fondamentale del suo sviluppo sociale, aveva alimentato una simile concezione della cultura, riconosceva l’importanza del patrimonio culturale di ogni popolo.
Anche se l’uso del termine cultura come attività intellettuale superiore è tuttora largamente diffuso, il concetto di cultura ha assunto per altro verso una veste scientifica, conquistando un posto di rilievo non solo nella storiografia o nella discussione filosofica, ma anche in discipline come l’antropologia, la sociologia, la psicanalisi e l’etologia.
Il contributo di Sigmund Freud ed altri illustri autori sia di formazione psicologica che sociologica, lo svilupparsi della riflessione filosofica tedesca, l’ascesa della scienza antropologica e l’avanzare di altre scienze vicine ad essa, come l’etnologia e la demologia, lo studio sul campo, come pratica “applicata” della scienza antropologica, il diverso destino che hanno avuto i termini cultura e civiltà, hanno contribuito al superamento (seppur non totale) del termine cultura come attività intellettuale superiore e all’introduzione di un nuovo e diverso concetto: la cultura è l’insieme delle conoscenze di un soggetto in quanto membro di una società.
La nozione antropologica di Cultura
In realtà non esiste una nozione antropologica di cultura. Ne esistono molteplici.
Nell’ultimo periodo dell’Ottocento si assiste a due fenomeni: l’antropologia si costituisce come scienza autonoma e inizia gli studi sull’origine e l’evoluzione della cultura.
Secondo la primissima teoria c.d. evoluzionistica, tutti i popoli hanno percorso, e sono destinati a percorrere, le medesime tappe: ciò che li differenzia è la durata della permanenza in ognuna di esse, la quale fornisce la chiave per comprendere il motivo del loro diverso grado di sviluppo culturale. Questa impostazione ha consentito, tra l’altro, di istituire uno stretto parallelismo tra la società antica e la struttura sociale dei popoli ancora allo stato primitivo, ritrovando in questi ultimi l’equivalente del passato preistorico del mondo europeo. Tutto ciò adottando il metodo comparativo come strumento di ricostruzione delle varie fasi del processo evolutivo della cultura.
Questa impostazione è stata oggetto di critica da parte della scienza antropologica successiva, che intende dimostrare l’infondatezza del presupposto di una evoluzione unilaterale.
Boas, nella sua opera The mind of primitive man (1911), sostiene che la cultura è oggetto d’apprendimento.
“La cultura – a parere dell’Autore – non è determinata dall’ambiente geografico, tant’è vero che forme di cultura differenti possono sorgere in ambienti simili e forme di cultura analoghe si presentano in ambienti quanto mai diversi”.
Da una diversa prospettiva parte, invece, Freud per delineare i tratti caratteristici della cultura. A parere dell’autore la cultura ha basi psichiche, per cui all’origine della cultura si trova una situazione traumatica corrispondente a quella che genera la nevrosi.
Ma le teorie antropologiche sulla cultura che più hanno avuto credito nel corso della storia contemporanea sono quelle che vedono la cultura non come un fenomeno evolutivo (o di origine psichica), bensì come fenomeni culturali individuali, ognuno dei quali nasce autonomamente e ha tratti di differenza o di analogia con le altre culture.
All’affermazione dell’autonomia della cultura si accompagna, in The mind of primitive man di Boas la considerazione delle varie culture come strutture sorte storicamente e comprensibili soltanto in base al loro particolare processo storico. Di conseguenza, l’antropologia assume a proprio oggetto non già la cultura, bensì le singole culture e i loro rapporti, lo sviluppo di ogni singola cultura e il complesso di relazioni che la lega con un determinato ambiente e con altre culture.
Il riconoscimento della pluralità delle culture rivela anche implicazioni importanti di ordine filosofico: il rifiuto della pretesa di ricondurre le diversità culturali a una matrice unitaria, la negazione dell’esistenza di valori assoluti comuni a tutte le culture, il rifiuto dell’etnocentrismo in quanto attribuzione illegittima di un valore privilegiato a una cultura particolare.
Tutto ciò ha rappresentato la base del relativismo culturale, inteso come affermazione dell’eguaglianza assiologica della varie culture e, al limite, della loro incomparabilità. W.G. Summer e A. Keller considerano lo sviluppo culturale come un processo di adattamento dei diversi gruppi sociali al loro ambiente specifico, che conduce ad adottare certe forme di comportamento e a escluderne altre, dando così luogo a una varietà di costumi tra loro irriducibili e parimenti legittimi. M.J. Herskovits, in chiave polemica afferma che tra le diverse culture non si possono stabilire giudizi di superiorità o di inferiorità tra le loro manifestazioni.
Questi ultimi autori appartengono ad un orientamento che possiede una nozione diversa e più complessa di antropologia culturale; il distacco dall’antropologia evoluzionistica e le diverse teorie che si sono succedute nel tempo hanno contribuito ad una nuova interpretazione di cultura. Si pensi all’importante contributo di Claude Lévi-Strauss, il quale ha applicato le teorie strutturalistiche alla scienza antropologica. Nella pratica dello strutturalismo, così come l’intende Lévi-Strauss, possono essere isolati due principi fondamentali:
- Una struttura che fa parte del reale, ma non delle relazioni visibili. Ogni realtà etnica è quindi formata da strutture che bisogna ben distinguere dalle singole relazioni sociali osservabili empiricamente; tali strutture elementari costituiscono un livello reale ma non percepibile direttamente.
- Lo studio scientifico delle realtà etniche deve essere diretto alla determinazione di queste strutture e al loro funzionamento: è lo studio sincronico di esse che rende conto dello sviluppo storico della società e non l’esame diacronico del loro sviluppo a offrire una spiegazione delle strutture presenti nelle realtà etniche. In poche parole Strauss adotta un sistema schematico per studiare le varie culture, dividendo in un asse immaginario le popolazioni secondo certe caratteristiche (uomini/donne; giovani/anziani; etc.) e, sulla base di queste “strutture”, analizza lo sviluppo della cultura.
Oggi la scienza antropologica è pressoché concorde nel considerare la cultura come un concetto relativo, come un complesso di conoscenze e di valori che ogni gruppo sociale, grande o piccolo, possiede e trasmette alle generazioni future. La nozione di cultura è legata infatti alla memoria: la cultura non è innata, ma continua a riprodursi attraverso la trasmissione dei c.d. folkways, che ne assicurano la sopravvivenza nonostante la transitorietà degli individui. Questo processo viene definito inculturazione (tipica prassi della Chiesa cattolica nei luoghi in cui esprime la propria evangelizzazione), e presenta spiccate analogie con quello di coltivazione il quale copre, come già abbiamo visto, uno dei livelli semantici della nozione di cultura.
A tal proposito occorre soffermarsi un attimo sul concetto di memoria. Il sociologo Franco Cassano, riprendendo alcuni concetti espressi da Agnes Heller, sostiene, all’interno di un’ampia riflessione sull’assolutizzazione della velocità nella società contemporanea, che l’accelerazione
“crea una perdita di sapere intergenerazionale e di apertura alla complessità del mondo che da questa menomazione deriva. La centralità dell’utile erode la memoria, perché l’interesse ha bisogno solo di una memoria a breve termine, non di una a lungo termine, e tanto meno di una memoria culturale; esso non crede nella ripetizione, è anticerimoniale. Laddove tutto può essere continuamente rinegoziato non c’è più spazio per la memoria, che diventa un impedimento, un ingombro, un limite alla libertà di movimento, che ha bisogno, se vuole essere assoluta, di dissolvere come un vincolo arcaico tutti i “cum”, sia nel tempo che nello spazio”.
La memoria, dunque, come sguardo critico verso il presente, mediante le esperienze del passato, ma non solo.
Memoria anche come un processo “metabolico” di trasformazione, in continuo divenire, attraverso il quale creare una identità collettiva in grado di rinnovarsi, senza perdere il contatto con la propria storia. l’identità può essere pensata come una “costruzione simbolica che per sussistere deve fondarsi principalmente sulla memoria” (U. Fabietti e V. Matera), perché identità e memoria sono intrinsecamente legate e si nutrono vicendevolmente in una catena infinita.
In conclusione
Quello di cultura è un concetto poliforme, racchiude numerosi significati e coinvolge diverse discipline. Dopo decenni di cultura di Stato, che ha imposto il concetto di cultura quale nozionismo stantio e volto a costituire nuove e inconsapevoli leve lavorative, e dopo la continua e costante disgregazione delle espressioni culturali individuali e collettive, soprattutto ad opera della cultura capitalistica, che ha fatto regredire le espressioni del folklore, ampiamente studiate da Gramsci, nei decenni a venire la discussione intorno alle espressioni culturali rappresenterà il primo e fondamentale tema volto al ripristino della coesione sociale e del rifondamento nazionale ed europeo.
E’ giocoforza prevedere che la tenuta socio-economica attuale non è più sostenibile e che presto occorrerà riprendere la discussione sulla Cultura come volano di ripristino e sviluppo di una società ormai allo sbando. Mi auguro che questo contributo possa in qualche modo servire a porre in essere una riflessione sul concetto di cultura e, soprattutto, sulla distinzione tra “cultura di Stato” e “Stato culturale”, una distinzione macroscopica, che rappresenta la differenza tra regime e autodeterminazione, soprattutto in una Nazione come l’Italia, in cui la Cultura – in passato – ha rappresentato un faro per la civilizzazione dei popoli europei e che oggi rappresenta una colonia di popoli che, fino a pochi secoli fa, erano considerati barbari e incolti.